Sei in: Rubrica Letture musicali » DANTE SYMPHONIE DI FRANZ LISZT
DANTE SYMPHONIE DI FRANZ LISZT
30/09/2021, 16:05
Questo è l’anno di Dante. Su Dante e sulla Divina Commedia non ho intenzione di soffermarmi. Ne sappiamo già tutti abbastanza (mi auguro) se non altro per averla studiata a scuola. Sappiamo che è per colpa di Boccaccio se chiamiamo Durante di Alighiero degli Alighieri semplicemente Dante Alighieri e sappiamo che è sempre colpa di Boccaccio se la Commedia è diventata Divina.
E sappiamo anche che il capolavoro dantesco ha ispirato una notevole produzione: studi, saggi, libri, documentari, programmi tv, pittura, teatro, persino videogiochi. E, naturalmente, musica.
Ed è di una musica (e di un compositore) in particolare che vorrei parlare oggi. La musica è la “Dante Symphonie” e il compositore è Franz Liszt.
Liszt era un compositore, pianista, organista e direttore d’orchestra ungherese (ma ha trascorso la sua vita a Vienna, a Parigi, in Italia e in mezza Europa in sostanza) vissuto tra il 1811 e il 1886, in pieno periodo romantico. Allievo di Carl Czerny (a sua volta allievo di Ludwig van Beethoven) ha avuto una certa importanza nella storia della musica: a parte lo sviluppo della tecnica pianistica fino ai limiti del possibile, che lo rende uno dei più grandi virtuosi di tutti i tempi, è stato l’inventore, tra le altre cose, del recital pianistico e del poema sinfonico e ha dedicato parte della sua vita a trascrivere per pianoforte (e quindi a diffondere e a far conoscere al grande pubblico) opere di autori come Beethoven e Schubert. Ebbe numerose amanti in tutta Europa e nel 1849 iniziò a manifestare una fede religiosa sempre crescente fino a quando, nel 1865 non ricevette gli ordini minori in Vaticano. Da questo momento in poi la sua musica è sempre più indirizzata verso temi religiosi.
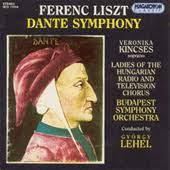
La Dante-Symphonie la compone tra il 1855 e il 1856, ma aveva iniziato a pensarci e a prendere appunti più di una decina d’anni prima. Al Journal des Zyi dichiara, nel 1839: “Intraprenderò una composizione basata sulla Commedia di Dante”. Così, il 7 novembre 1857, fu Liszt stesso a dirigere la prima esecuzione dell’opera all’Hoftheater di Dresda. E fece una figuraccia. L’orchestra aveva provato poco e male e il pubblico non era abituato a musica del genere. Così la volta successiva (Praga, 11 marzo 1858), imparata la lezione, Liszt preparò meglio l’orchestra ma anche il pubblico, con la distribuzione di un programma di sala dove si spiegava il lavoro e si davano al pubblico gli elementi per comprenderlo e apprezzarlo.
Naturalmente qui sarebbe difficile, con uno spazio limitato analizzare in modo approfondito un’opera che dura circa cinquanta minuti. E sarebbe anche inutile. Cercherò pertanto di darne una descrizione sommaria, una sorta di mappa che consenta all’ascoltatore di orientarsi.
L’opera è divisa in due parti: L’inferno e il Purgatorio. Sembra che Liszt avesse in mente anche di comporre un movimento dedicato al Paradiso ma Richard Wagner, suo amico e genero, glielo avrebbe sconsigliato adducendo la motivazione che il Paradiso è il regno di Dio e quindi neppure la musica può rappresentarlo. Liszt rinuncia a scrivere il Paradiso ma conclude il Purgatorio con un coro femminile che canta un Magnificat e un Alleluia.
Entrambi i movimenti sono divisi in episodi che richiamano alcuni momenti salienti dell’opera dantesca e Liszt annota i versi della Commedia a cui intende riferirsi. Così, per esempio, all’inizio della partitura sono annotati i versi che, nel Canto III, Dante vede scritti sulla porta dell’Inferno. Via via si susseguono, senza soluzione di continuità gli episodi: l’anticamera dell’inferno e il Limbo, Paolo e Francesca, il Settimo Cerchio e una coda che presumibilmente rappresenta Dante e Virgilio che escono all’aperto, davanti alla montagna del Purgatorio.
Il secondo movimento è diviso in tre parti, rappresentando la suddivisione dantesca: l’antipurgatorio, il Purgatorio vero e proprio con le sue sette cornici e infine il Paradiso (rappresentato, come già accennato, da un coro femminile che intona il Magnificat). Nel Purgatorio Liszt rappresenta il pianto e i gemiti dei penitenti annotando sulla partitura specifiche notazioni per gli esecutori come “gemendo”, o “dolente e appassionato”: significa che suonando bisogna cercare di dare quella determinata intenzione alla musica, esprimere col suono dolore e lamento.
Nell’ultima sezione, Magnificat e Alleluia, Liszt chiede un coro di voci femminili (o, in alternativa, voci bianche), con il preciso intento di rappresentare un coro angelico; fa di più: sulla partitura prescrive esplicitamente che il coro canti nascosto alla vista del pubblico, possibilmente stando in alto quando possibile, sopra l’orchestra. Il primo verso del Magnificat è intonato da una voce solista, che probabilmente rappresenta Beatrice. Viene rappresentata quindi l’ascesa di Dante tra le Sfere Celesti. Il brano finisce con il coro che intona fortissimo un Alleluia, a rappresentare Dante che finalmente arriva all’Empireo.













